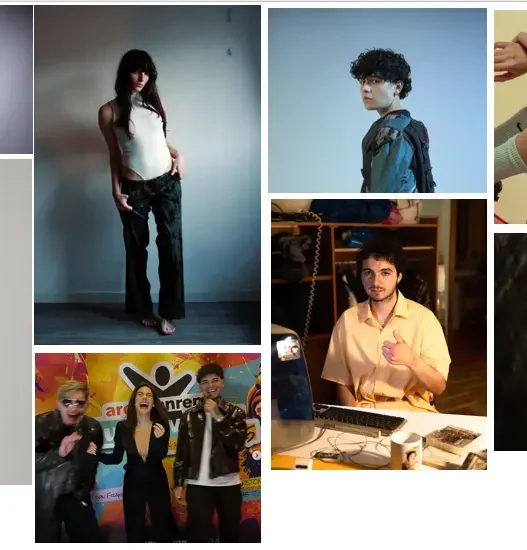Un nome, un destino. Tommaso La Notte ama la notte e fa cose di notte. Scrive, soprattutto, di tutto ciò che gli accade. Lui lo chiama il “La” della vita, il caos che trasforma in musica e parole, come “Shampoo alla camomilla”, il suo ultimo singolo.
Tommaso la Notte non ha dubbi. Il suo momento preferito del giorno, inizia al calare del sole. “L’amore per la notte nasce spontaneamente come quando preferisci un gusto di gelato piuttosto che un altro: non sai perché, ma sai che accade, e va bene così”, spiega. “Sin da piccolo mi accadeva di sentire un turbamento interiore tendenzialmente durante il tramonto, era una specie di malinconia che mi attanagliava la gola, lasciandomi senza respiro. Non succedeva ogni sera, accadeva sporadicamente. Quando arrivava il buio e la notte, mi sentivo libero da quella sensazione, mi si scioglieva nel petto e nella gola quel nodo di malinconia. Da allora probabilmente ho accostato la notte ad un rifugio personale dalla vita sociale, dalle proprie malinconie diurne, dalle paure, dal futuro. La notte è il mio cognome ed è la mia casa, è dove e quando anestetizzo il presente.
“Shampoo alla camomilla” parla della sensazione che resta dopo un amore finito. Hai raccontato una tua esperienza personale? Com’è nata questa canzone?
Racconto sempre di quello che mi accade, non perché penso che la mia vita sia migliore di altre o che abbia vissuto più esperienze di altri e altre – tanto più che la mia è una vita ordinaria -, ma perché è solo con il La della vita che mi si scatena l’orchestra di turbamento e caos che tramuto in musica e parole. Quello che cerco è universalizzare con la poesia le mie esperienze, scrivere di esperienze particolari nel modo più
universale possibile, non perché debba per forza piacere a chi mi ascolta e neanche perché scrivo quello che il pubblico vorrebbe sentirsi dire, ma perché non c’è arte del particolare, c’è arte quando c’è la ricerca dell’umanità intera in una singola vicenda umana. Quindi si, è una esperienza personale, ma c’è anche una ricerca che vada oltre questa esperienza.

Chi ci salva dalle delusioni d’amore, secondo te? Noi stessi, la famiglia, gli amici, la musica, il tempo, nessuno?
Sostanzialmente siamo noi a tirarci fuori dai noi stessi che soffrono. Possiamo farci aiutare da amiche, amici, famiglia, musica, arte, progetti, concerti, quadri, libri…ma alla fine siamo sempre noi a scrollarci di dosso il peso del turbamento. Subentra ad un certo punto una fortissima autoconservazione che ci fa scoprire molto più forti di quello che credevamo: la musica, le altre persone, il tempo sono solo gli strumenti con cui ci salviamo. Le mani che ricostruiscono tutto sono alla fine dei conti le nostre.
La canzone si chiude parlando del senso, l’agognato senso, che forse non troviamo perché non esiste. Si può vivere accettando questa possibilità?
È una domanda veramente immensa. Forse “La Domanda”. Intendiamoci, di quale senso stiamo parlando? Universale e trascendente? O particolare e transeunte? Mi viene in mente il discorso del “Credo” nel film Radiofreccia. Penso che sia fondamentale essere in grado di costruirsi un senso, una maschera, tracciare un solco che ci faccia camminare sempre, che ci dia sempre una motivazione per svegliarci ogni mattina e spingerci a migliorarci. Ognuno dovrebbe costruirsi un senso o scegliere di non costruirsene uno e limitarsi a vivere, mi mette paura però la possibilità di non riuscire a costruirne uno, di non riuscire a scovarne uno. È una forma di nichilismo individuale che può portare solo all’annientamento dell’io: non riuscire a trovare il proprio senso. Tutto il resto, il trascendente, il senso universale… è frutto della curiosità dell’uomo pre- scientifica che si è espressa con miti, leggende e ha tentato di scovare la “teoria del tutto” bussando
all’immensità e all’infinito con i pochi strumenti di analisi che possedeva. Prediligo il senso particolare, individuale, il senso delle piccole cose quotidiane.
Ma se stiamo male per amore, allora forse l’amore un senso deve averlo…che ne pensi?
C’è una canzone bellissima di Fabi Silvestri Gazzè che ne parla. Se l’amore non esiste, non esiste neanche il senso dell’amore. Mi piace parlare piuttosto di senso della quotidianità, l’insieme di piccole cose quotidiane che ci fanno sentire vivi. L’amore è tra queste, è questo. Il senso? Penso che l’amore sia senso, non abbia senso. Per questo quando perdiamo amore ci sembra di perdere senso, non perdiamo il senso dell’amore, ma una parte di senso della quotidianità.
Sei appassionato di letteratura. Ci consigli un libro da leggere in quest’ultima settimana di agosto?
Per gli appassionati di letteratura americana consiglio “Chiedi alla Polvere” di John Fante: un capolavoro dolceamaro su uno scrittore italoamericano che non viene riconosciuto artista praticamente da nessuno e vive scisso tra l’italianità delle sue origini familiari e l’America. Mentre per gli appassionati di letteratura italiana consiglio un autore di cui sono rimasto folgorato: Pier Vittorio Tondelli. Ho quasi pianto con “Camere separate” e ho riso, mi sono sentito vivo, ho percepito tutta l’umanità decadente di provincia leggendo “Altri libertini”. Poi scrivetemi cosa ne pensate quando e se li leggerete.

Sei uno studente di Filosofia. Come mai hai scelto questa facoltà?
Ho scelto filosofia dopo aver letto “L’eleganza del riccio”, ma probabilmente era una scelta che covavo inconsciamente da sempre. Ho scelto filosofia perché mi sono sempre piaciute le domande senza una risposta definitiva, quelle domande immense che molte volte vengono trattate con superficialità, ma nelle quali la filosofia si siede e riflette e propone soluzioni, quasi sempre potenzialmente aperte. Mi affascina
che la filosofia scava dove il senso comune costruisce castelli di granito su fondamenta di marmo. E poi probabilmente perché mi sono sempre sentito solo, mentre studiando i filosofi mi sono ritrovato molte volte in compagnia, probabilmente è la stessa sensazione che prova chi studia lettere o storia della musica, o storia dell’arte…
Com’è stato il passaggio da una realtà come quella di Giovinazzo a Torino?
Giovinazzo è un posto bellissimo, è casa, è il luogo dove sono nato e anche da dove sono fuggito e dove adesso torno qualche mese l’anno. È la sostanza del mio modo di vedere la vita, di mangiare, di sentirmi italiano, di sentirmi europeo e cittadino del mondo. È il filtro da cui osservo le piccole cose. Prima di tutto il resto, nel mio sangue, sulla mia pelle c’è la Puglia. Dall’altro lato c’è Torino, c’è “casa nuova”, ci sono tutte
le persone stupende che ho incontrato, c’è un modo di vivere che non mi appartiene e con il quale convivo quasi sempre pacificamente, ma sempre come un estraneo. Che poi ci siano più meridionali a Torino che al sud è un altro discorso. Torino è ancora un’incognita per me, devo ancora decifrarla, sempre che ce ne sia bisogno: mi piace questo senso di straniamento, questo procedere a tentoni per strade che conosco poco, questo calarmi leggermente in abitudini che non mi appartengono, ma alle quali posso giocare per un po’. Anche quando sono a Torino, però, torno sempre con la mente alla “Amara Terra Mia”.
Com’è che hai cominciato a suonare e a fare musica?
Per caso. Non ero appassionato di musica prima di iniziare a suonare, per me c’era solo il calcio. Ho sempre ascoltato in casa i cantautori italiani, il rock, la musica classica, il jazz… ma nulla mi prendeva in modo viscerale. Quando ero piccolo l’unica volta che mi sono sentito totalmente preso da un musicista era stato con Alex Britti: mi faceva impazzire il modo in cui suonava la chitarra. Poi c’è stato un corso estivo di chitarra in cui ho scoperto che mi sarebbe piaciuto approfondire lo studio dello strumento e infine è arrivato il primo concerto di Niccolò Fabi: fu amore a primo ascolto. Da quel momento sentì che era arrivato il momento di scrivere, provare a mettere in musica le mie suggestioni. Questa è stata la mia porta sul cantautorato.
Qual è la canzone che ti ha cambiato la vita?
Una canzone che torna spesso a bussarmi è “La grande Cascade” di Renè Aubry. Il suo è stato il primo concerto a cui ho assistito nella pancia di mia madre e la sensazione di leggerezza che riesce a procurarmi quella canzone è imbattibile, mi fa sentire come fossi in mare aperto. Ma probabilmente la canzone che davvero mi ha cambiato la vita è stata “Costruire”. Sin dal primo “Chiudi gli occhi” ho sentito la voce
dell’infinito che mi parlava. Lì ho capito quale bellezza era possibile con il cantautorato, quale mondi dischiudevano quelle sei corde. Quando ho ascoltato per la prima volta “Costruire” mi sono sentito trascinato in uno di quei mondi e rigettato subito dopo nella normalità della quotidianità con la necessità di costruirne di miei.
“Nostalgia” è una canzone bellissima. Si deve avere paura di questo sentimento?
La nostalgia è una condizione esistenziale dolceamara: è la sofferenza del ritorno. È un ossimoro, è duale. Può risultare strano che io abbia scritto un EP che parla interamente di nostalgia a soli 15 anni, ma per me la nostalgia non è quello che normalmente viene attribuito a questa parola; per me nostalgia è il senso di assoluto, è il terrore dell’immenso, è l’infinito di Leopardi. La nostalgia è un briciolo di infinito che ci si
impantana nelle costole quando non ce l’aspettiamo e che ci fa desiderare di far tornare quello che il tempo ha distrutto irrimediabilmente. La nostalgia è l’infinito che si districa tra il tempo presente, il passato e il futuro; è la nostra avversione all’irrimediabile.
Qual è la cosa che ti manca di più e di cui hai nostalgia, se c’è.
Mi manca mangiare il gelato con i miei genitori nei pomeriggi di marzo in piazza quando avevo cinque anni. Quel senso di ovattata felicità infantile.